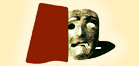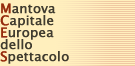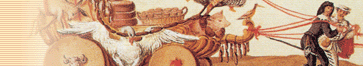LE GROTTESCHE DI PALAZZO BERLA di
Umberto Artioli
 |
Mantova,
Palazzo Berla
Scena di cucinatura della
selvaggina |
Fa sensazione la scoperta di una serie
di affreschi a grottesca contenenti scenette della Commedia
dell’Arte, rinvenuti a Mantova durante i lavori di
ristrutturazione di Palazzo Berla. Posti in fregio al
soffitto di una sala del palazzo quattrocentesco, oggi sede
del Collegio Notarile, gli affreschi sono otto, ma in tre di
essi la vignetta centrale è andata perduta.
Anche se lo stato di conservazione
delle immagini è alquanto degradato, qualcosa è lecito
dedurre dalle sequenze superstiti: l’ignoto affrescatore
ha raffigurato scene di danza e di caccia, traendo spunto
dai cosiddetti ludi zanneschi, ossia da forme di
intrattenimento legate al contrasto tra Pantalone e lo
Zanni.
Ma cosa significa il ricorso a motivi
dell’improvvisa (o a forme d’intrattenimento che le sono
connesse) in un palazzo privato e, soprattutto, cosa
imparenta la danza e la caccia che qui appaiono curiosamente
legate?
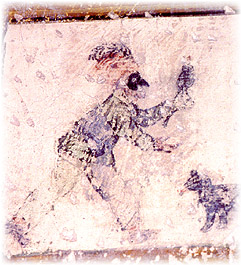 |
Mantova,
Palazzo Berla
Scena di danza |
Fissiamo un particolare: in origine la
sala dove si trovano gli affreschi disponeva di un camino.
Nella figura sovrastante l’antico luogo del camino è
raffigurato un fornello da campo da cui sprizzano fiamme; il
fornello è posto su un tripode e ai suoi piedi sta una
bacinella.
Attorno alle presenze oggettuali che funzionano
da centro della composizione, sono disposte le figure dei
comici secondo uno schema rigorosamente triadico, ripreso
del resto nell’intera serie di affreschi: a sinistra
Pantalone porge un uccello; al centro uno Zanni sorregge una
padella; a destra un secondo Zanni assiste all’azione. Il
tema è replicato con varianti in altre due scenette.
Nella
prima uno Zanni, posto a sinistra, si protende verso le
altre figure sorreggendo un uccello. Indossa la semimaschera
nera tipica del ruolo e un ampio copricapo rosso, con sulla
cima un pennacchio verde; dello stesso colore del piumaggio
è il camicione rituale, che risalta contro i pantaloni
bianchi.
Posto di profilo, sta in posa plastica, il piede
destro sollevato, il corpo proteso in avanti. Contro di lui,
sempre di profilo e nella stessa postura, anche se
simmetricamente contrapposte, avanzano due figure poco
individuabili, ma probabilmente due Zanni, uno dei quali
sorregge un uccello di maggiori dimensioni.
Al centro della
raffigurazione sta un cane. È questa l’unica sequenza in
cui manca Pantalone, chiaramente riconoscibile invece nella
terza vignetta del ciclo venatorio. Dotata dei tradizionali
connotati (il naso a becco, la semimaschera, la lunga barba
appuntita in tipico stile cinquecentesco, la calzamaglia
rossa, le ciabatte) la maschera veneziana che regge a sua
volta un uccello, sembra in partenza per la caccia. Lo
dimostra la presenza del cane che lo precede, avanzando
nell’estremità destra della composizione.
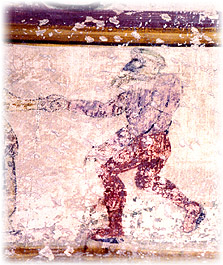 |
Mantova,
Palazzo Berla
Scena di danza |
Quasi esitante,
intento a carpire gli ultimi consigli dei suoi
interlocutori, Pantalone ha la testa girata all’indietro,
nella posa plastica che ne contraddistingue i moduli
recitativi: gli fa da contrappeso uno Zanni centrale che,
toccandogli la spalla con la mano, lo risospinge nella
direzione del cane, mentre un secondo Zanni, dall’estrema
sinistra, osserva l’azione.
Sopra il cane, nella parte più
luminosa dell’affresco, c’è una figura miniaturizzata,
a braccia aperte e gambe divaricate: forse un diavoletto o
un altro Zanni gulliverizzato. Particolare curioso, in
nessuna delle scenette di caccia esistono armi che non siano
gli spadini di latta comuni alle maschere, né sono
ravvisabili gli spunti aggressivi, gli sberleffi e i modi
ferocemente caricaturali che contraddistinguono i ludi
zanneschi, dove Pantalone è esposto al lazzo dei servi.
Nelle scene venatorie di Palazzo Berla si respira un’aria
distesa e pacata, la stessa che avvolge le composizioni
ispirate alla danza. Nella prima di queste Pantalone,
raffigurato al centro in una sorta di gesto reverenziale, si
protende verso uno Zanni musico che suona uno strumento a
fiato; dalla parte opposta un secondo Zanni, con la mano
levata, scandisce i tempi della danza.
Nella seconda, fortunatamente la meglio
conservata, compare quel che si può definire un autentico topos
dell’epoca. Mentre lo Zanni musico, sempre da sinistra,
con una mano sorregge il flauto e con l’altra, protesa
verso l’alto, batte il ritmo, Pantalone all’estrema
destra è impegnato a danzare. Questa volta tuttavia non
danza solo: regge per mano una dama elegantemente vestita,
la cui rigidità contegnosa impatta con la postura dinamica
e scattante della maschera veneziana.
Tra le due scenette è
lecito intravedere un rapporto di successione: nella prima i
servi, trasformati in pedagoghi, insegnano a Pantalone i
protocolli mondani dell’arte di sedurre; nella seconda
tali protocolli conoscono la loro applicazione.
 |
Mantova,
Palazzo Berla
Scena di danza |
Vediamo di tirare le somme. In quattro
affreschi su cinque è presente Pantalone; onnipresente è
lo Zanni. Come le scene di caccia, frazionate tra momenti
iniziali e finali, tra i preparativi per il rituale
venatorio e il consumo della selvaggina, sembrano suggerire
una sequenzialità, così nelle scene di danza c’è
l’apprendistato di Pantalone, ma anche l’esito di questo
apprendistato, ossia il ballo con la dama. A questo punto
sembra possibile avanzare l’ipotesi che la committenza
abbia inteso allietare con i tipi dell’Arte una sala da
banchetto, ossia un luogo di piacere tanto gastronomico che
legato alla sfera del ballo. Palazzo Berla, in origine
posseduto dalla famiglia nobiliare dei Cavriani, viene
acquistato nel 1558 dai Bonsignori, una famiglia di mercanti
proveniente da Lodi e stabilitasi a Mantova agli inizi del
Cinquecento. Poiché i Bonsignori, mantengono
ininterrottamente la proprietà sino al 1643 e le grottesche
che ornano la sala sono databili tra il 1580 e il 1600, si
può dare per certo che proprio i Bonsignori siano i
committenti.
Ma se l’incarico di dipingere gli
affreschi viene da una famiglia di mercanti, è anche lecito
supporre che Pantalone, prototipo del mercante, possa essere
stato assunto dalla proprietà a simbolo della propria
categoria professionale. Ciò spiegherebbe perché la
maschera veneziana sfili nelle grottesche di Palazzo Berla
in versione nobilitata, senza gli sberleffi e gli
ammiccamenti sull’avarizia o sulla sessomania che ne
contraddistinguono la partitura abituale. In uno dei più
noti scritti del Cinquecento un mantovano celebre,
Baldassare Castiglione, insegna le buone maniere all’uomo
di corte; nelle scenette di Palazzo Berla l’ammaestramento
concerne la classe borghese: Pantalone, avviato ai segreti
della caccia, del ballo e della cucina, assume lo Zanni a
guida nell’arte del Piacere. Da esperto in oscenità e
ribalderie, il servo dell’improvvisa diventa il centro di
un’esperienza galvanizzante: affiancare all’industre
operosità del lavoro di mercatura, i rudimenti della gioia,
le raffinatezze dell’arte di godere.
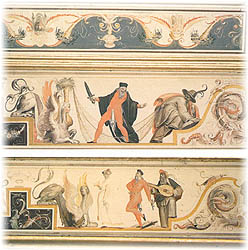 |
Antonio Ponzano
Decorazione in fregio al soffitto
Castello di Trausnitz (Baviera) |
Gli affreschi del palazzo mantovano, di modesta fattura,
possono risultare poco significativi per lo storico
dell’arte, attento alla loro valenza estetica. Assumono
invece un eccezionale rilievo per lo storico del teatro
trattandosi dell’unico reperto del genere presente in
Italia sulle origini della Commedia dell’Arte. I repertori
iconografici a cui si suole fare riferimento per
circoscrivere gli esordi dell’improvvisa sono in linea di
massima due: la collezione di stampe Fossard, conservata in
parte a Stoccolma e in parte a Copenhagen; il castello di
Trausnitz in Baviera, sede della celebre Narrentreppe (Scala
dei folli) ma anche delle miniature a grottesca poste in
fregio al soffitto della stanza di lavoro di Guglielmo V,
che sono in tutto sedici, un numero che può avere qualche
consonanza con le otto mantovane. Fossard era un musicista
della corte di Luigi XIV, incaricato da Re Sole di radunare
tutte le testimonianze iconografiche sulla Commedia
dell’Arte. La sua raccolta, che mette insieme incisioni di
epoche diverse, solleva perciò non pochi problemi di
datazione. Certa è invece la collocazione temporale dei
reperti di Trausnitz, trattandosi del periodo compreso tra
1576 e 1578. Tra gli affreschi mantovani e i repertori
citati esiste una tessera comune: in tutti ricorre il motivo
di Pantalone che danza con una dama più o meno compassata,
al suono di uno Zanni musico. Potrebbe essere questo un
elemento importante per una migliore datazione delle
grottesche di Palazzo Berla. Nelle miniature di Trausnitz il
motivo della danza ricorre in più varianti: c’è Zanni
che tiene per mano sia Pantalone che la dama, in una posa da
ruffiano; c’è Pantalone che va incontro alla Bella
Sconosciuta mentre Zanni è intento a suonare; c’è Zanni
che approfitta della situazione, volteggiando con la donna,
mentre Pantalone, lasciato in disparte, sembra dissentire;
c’è infine il trio dei maschi (Pantalone, uno Zanni e
un’altra figura non ben identificabile) intento a far
musica. Sono noti i frequenti contatti tra il Ducato di
Mantova e la Baviera, divenuti ancora più stretti quando
nel 1591 il cremonese Antonio Maria Viani, dopo aver
trascorso cinque anni in Baviera al servizio di Guglielmo V,
si trasferisce a Mantova in qualità di prefetto alle
fabbriche. Ma l’ipotesi di un’eventuale attribuzione a
Viani, abilissimo inventore di grottesche, di un qualche
ruolo nella messa a punto degli affreschi di Palazzo Berla,
così incerti dal punto di vista grafico e compositivo, è
sicuramente da scartare. Più probabile è che l’ignoto
affrescatore di Mantova abbia operato sulla scorta di un
modello, presumibilmente una stampa popolare, da lui
replicato con scarsa inventiva.
 |
Ambrogio Brambilla
Incisione presente nel
Recueil Fossard Copenhagen |
E proprio nella collezione
Fossard esistono le tracce di questo possibile modello. Il
riferimento va alla serie di nove incisioni, fino a qualche
tempo fa identificate col solo nome della stamperia romana
presso cui sono state edite e attribuite di recente da
Margret Katrizky al milanese Ambrogio Brambilla. Una di
queste, presente anche in un’altra versione munita di
didascalie (probabilmente una nuova stampa) presso il
British Museum, denota forti analogie con la scena del ballo
tra Pantalone e la dama presente a Palazzo Berla. La scena a
cui ci si riferisce si svolge in un esterno appena accennato
dagli avvallamenti del terreno. Lo Zanni compare a sinistra,
più o meno nell’abbigliamento e nella postura di Mantova;
avendo le mani impegnate a sorreggere il flauto, detta il
ritmo col piede destro, che appare sollevato. Come in tutta
la serie di Brambilla, la composizione è triadica e se, a
differenza di Mantova, Pantalone è raffigurato al centro
con la dama sul fianco, l’atteggiamento della coppia resta
immutato: impettita e rigida lei; scattante e dinamico nella
sua attillata calzamaglia il vecchio barbuto. Non si conosce
l’esatta data di composizione delle nove incisioni
attribuite ad Ambrogio Brambilla. Certo è invece che nel
periodo milanese l’incisore, trasferitosi da Milano a Roma
nel 1575, era, con Simone di Bologna (in arte Zan de Pegora),
uno dei soci del circolo dei Rabisch, l’accademia di Val
di Blenio che, fondata nel 1560, assumeva a modello la
direttrice grottesca presente in Leonardo e imitava le
cadenze dei facchini emigrati a Milano dalle valli del Nord.
Precisi sono gli interessi di Brambilla per la componente
caricaturale della Commedia dell’Arte, testimoniati tra
l’altro dalla coppia di incisioni, risalenti al 1583,
dedicate al Ballo di Zan Trippa e alla Cucina per il pasto
di Zan Trippa neo-sposo. Assumere a soggetto l’improvvisa,
mettendo insieme il motivo del banchetto con quello della
danza, era dunque qualcosa di compatibile con lo spirito del
tempo. È quindi plausibile che l’ignoto affrescatore
mantovano, senza ricorrere alla Baviera, potesse trovare
nella cultura lombarda un adeguato punto di riferimento.
Resta un ultimo punto su cui meditare: nelle scenette di
Palazzo Berla manca Arlecchino, la maschera che, stando agli
studi recenti, è stata inventata a Parigi tra 1584 e 1585
da un altro mantovano celebre, Tristano Martinelli.
Martinelli era l’attore prediletto da Vincenzo I Gonzaga,
il duca che dà vita alla prima compagnia italiana di Stato,
selezionando ruolo per ruolo i maggiori interpreti della
Commedia dell’Arte. Ciò lascia presumere che i dipinti di
Palazzo Berla siano anteriori all’epoca in cui dallo
stuolo degli Zanni fuoriesce Arlecchino o, al più,
coincidenti con essa. In base a tale ipotesi la data di
composizione degli affreschi mantovani andrebbe ristretta al
periodo compreso tra 1578 e 1585.
Articolo comparso in «Primafila», n.
52, febbraio 1999, pp. 20-25
|
|